Da F. Capra, Il Tao
della fisica
AL
DI LÀ DEL MONDO DEGLI OPPOSTI
UNITÀ CHE TUTTO COMPRENDE
Quando i
mistici orientali ci dicono che essi percepiscono tutte le cose e tutti gli
eventi come manifestazioni di una fondamentale unicità, ciò non significa che
essi asseriscano che tutte le cose sono uguali. Essi riconoscono l'individualità delle cose, ma nello stesso tempo sono
consapevoli che tutte le differenze e
tutti i contrasti sono relativi, all'interno di un'unità che tutto
comprende. Poiché nel nostro stato di coscienza normale questa unità di tutti i
contrasti – e in particolare l'unità degli opposti – è estremamente difficile
da accettare, essa costituisce uno degli aspetti più sconcertanti della
filosofia orientale. Tuttavia è un'intuizione che sta alle radici stesse della
concezione orientale del mondo.
Gli
opposti sono concetti astratti che appartengono al mondo del pensiero e in
quanto tali sono relativi. Con il solo atto di concentrare la nostra attenzione
su un qualsiasi concetto noi creiamo il suo opposto. Come dice Lao-tzu, «tutti nel mondo
riconoscono il bello come bello; in questo modo si ammette il brutto. Tutti
riconoscono il bene come bene; in questo modo si ammette il non-bene». Il
mistico trascende questo mondo dei concetti intellettuali, e nel trascenderlo
diventa consapevole della relatività e del rapporto polare di tutti gli
opposti. Egli si rende conto che buono e cattivo, piacere e dolore, vita e
morte non sono esperienze assolute che appartengono a categorie diverse, ma sono semplicemente due facce della stessa realtà:
le parti estreme di un tutto unico. Raggiungere la consapevolezza che tutti gli
opposti sono polari, e quindi costituiscono un'unità, è considerato nelle
tradizioni spirituali dell'Oriente una delle più alte mete dell'uomo. «Sii
eterno nella verità, al di là delle opposizioni terrene» è il consiglio di Krsria nella Bhagavad Gita, e lo
stesso consiglio viene dato ai seguaci del Buddhismo.
Per esempio, D.T. Suzuk iscrive:
«L'idea
fondamentale del Buddhismo è di superare il mondo
degli opposti, un mondo costruito dalle distinzioni intellettuali e dalla
corruzione delle emozioni, e di comprendere il mondo spirituale della
non-distinzione, che comporta il conseguimento di un punto di vista assoluto».
L'intero
insegnamento buddhista - e di fatto tutto il misticismo orientale - ruota attorno a questo punto di vista assoluto
che viene raggiunto nel mondo di a-cintya , o
«non-pensiero», nel quale l'unità di tutti gli opposti diviene una esperienza
viva. Dice una poesia Zen:
Al crepuscolo il
gallo annunzia l'aurora;
A mezzanotte, il
sole risplendente.
EQUILIBRIO
DINAMICO degli opposti
L'idea
che tutti gli opposti sono polari - che
luce e buio, vincere e perdere, buono e cattivo sono soltanto differenti
aspetti dello stesso fenomeno - è uno dei princìpi
fondamentali del modo di vita orientale. Poiché tutti gli opposti sono
interdipendenti, il loro conflitto non può mai finire con la vittoria totale di
uno dei poli, ma sarà sempre una manifestazione dell'azione reciproca tra l'uno
e l'altro polo. In Oriente, una persona virtuosa non è perciò quella che
affronta l'impossibile compito di battersi per il bene e di sconfiggere il
male, bensì quella che è capace di
mantenere un equilibrio dinamico tra il bene e il male.
Questa
idea di equilibrio dinamico è essenziale per il modo in cui l'unità degli
opposti è sperimentata nel misticismo orientale. Non è mai un'identità statica,
ma sempre un'interazione dinamica tra d u e estremi. Questo punto è stato messo
in evidenza in modo particolarmente ampio dai saggi cinesi con il loro
simbolismo dei poli archetipici yin
e yang. All'unità soggiacente allo yin e allo yang essi davano il
nome di Tao e la consideravano come un processo che determina la loro azione
reciproca: «Quello che fa comparire una volta l'oscuro ed una volta il chiaro,
è il Senso [il Tao]».
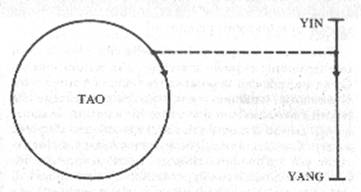
Unità dinamica degli opposti polari
L'unità
dinamica degli opposti polari può essere illustrata con il semplice esempio di
un moto circolare e della sua proiezione. Si consideri un punto che si muove
lungo una circonferenza. Se questo movimento viene proiettato su uno schermo,
esso diventa una oscillazione tra due punti estremi. Il punto gira sulla
circonferenza con velocità costante, ma nella proiezione rallenta quando
raggiunge le estremità, inverte il moto e quindi accelera di nuovo, poi rallenta
ancora una volta e così via, in cicli senza fine. In ogni proiezione di questo
tipo, il moto circolare apparirà come un'oscillazione tra due punti opposti, ma
nel movimento stesso gli opposti sono unificati e superati. Questa immagine di
una unificazione dinamica degli opposti era in realtà profondamente radicata
nella mente dei pensatori cinesi, come si può vedere dal passo del Chuang-tzu già citato:
«Che
l'"io" e l'"altro" non siano più in contrapposizione è la
vera essenza del Tao. Solo questa essenza, che appariva come un asse, è il
centro del cerchio che risponde ai mutamenti perenni».
IL MASCHILE E IL FEMMINILE
Una
delle principali polarità della vita è quella tra il lato femminile e quello
maschile della natura umana. Come succede con la polarità tra buono e cattivo o
tra vita e morte, tendiamo a sentirci a disagio di fronte alla polarità
maschio/femmina che è in noi stessi, e siamo quindi portati a dare risalto a
uno o all'altro di questi aspetti. La società occidentale ha tradizionalmente
favorito più l'aspetto maschile che quello femminile. Invece di riconoscere che
la personalità di ogni uomo e di ogni donna è il risultato di una azione
reciproca tra l'elemento maschile e quello femminile, essa ha stabilito un
ordine statico in cui si suppone che tutti gli uomini siano maschili e tutte le
donne femminili, e ha assegnato all'uomo i ruoli guida e la maggior parte dei
privilegi della società. Questo atteggiamento si è tradotto in una eccessiva
importanza data a tutti gli aspetti yang - o maschili - della natura umana: attività, pensiero razionale,
competitività, aggressività, e così via. Le modalità di coscienza yin - o femminili -
che possono essere descritte con termini quali intuitivo, religioso, mistico,
occulto o psichico, sono state costantemente soffocate nella nostra società di
tendenze maschiliste.
Nel
misticismo orientale, queste modalità femminili vengono sviluppate e si cerca
di realizzare un'unità tra i due aspetti della natura umana. Un essere umano
pienamente realizzato è quello che, secondo le parole di Lao-tzu,
«sa d'esser maschile e si mantiene femminile». In molte tradizioni orientali,
l'equilibrio dinamico tra le modalità di coscienza maschile e femminile è lo
scopo principale della meditazione ed è spesso illustrato in opere artistiche.
Una stupenda scultura di Siva nel tempio indù di Elephanta presenta tre facce del dio: sulla destra, il suo
profilo maschile che mostra virilità e forza di volontà; a sinistra, il suo
aspetto femminile - dolce, affascinante, seducente - e nel centro la sublime unione dei due aspetti
nella magnifica testa di Siva Maheśvara,
il Grande Signore, che irradia serena tranquillità e distacco trascendente.
Nello stesso tempio, Siva è anche rappresentato in
forma androgina, metà uomo, metà donna; i movimenti sinuosi del corpo del dio e
il sereno distacco della sua faccia simboleggiano, di nuovo, l'unificazione
dinamica del maschio e della femmina.
Nel Buddhismo tantrico, la polarità
maschio/femmina è spesso illustrata con l'aiuto di simboli sessuali. La saggezza
intuitiva è vista come la qualità passiva, femminile, della natura umana,
l'amore e la compassione come la qualità attiva, maschile, e l'unione di
entrambe nel processo di illuminazione è rappresentata con estatici amplessi
sessuali di divinità maschili e femminili. I mistici orientali affermano che si
può avere l'esperienza dell'unione della propria mascolinità e della propria
femminilità solo quando si è raggiunto un livello superiore di coscienza, nel
quale il mondo del pensiero e del linguaggio è trasceso e tutti gli opposti
appaiono come un'unità dinamica.
L’UNIONE DEGLI OPPOSTI NELLA
FISICA MODERNA
Ho già
sostenuto che un livello di questo genere è stato raggiunto nella fisica
moderna. L'esplorazione del mondo subatomico ha rivelato una realtà che
continuamente trascende il linguaggio e il ragionamento, e l'unificazione di
concetti che finora erano sembrati opposti e non conciliabili risulta essere
una delle più sorprendenti caratteristiche di questa nuova realtà. Questi
concetti apparentemente inconciliabili non sono generalmente gli stessi di cui
si occupano i mistici orientali - sebbene talvolta lo siano - ma la loro
unificazione a un livello di realtà non ordinario corrisponde all'unificazione
di cui parla il misticismo orientale. I fisici moderni dovrebbero perciò essere
in grado di raggiungere una comprensione profonda di alcuni dei principali
insegnamenti dell'Estremo Oriente col metterli in relazione con le esperienze
che essi hanno nel loro specifico settore di studio. In effetti, un piccolo ma
crescente numero di giovani fisici ha trovato così il più valido e stimolante
approccio al misticismo orientale.
Nella
fisica moderna, esempi di unificazione di concetti opposti si possono trovare a
livello subatomico, dove le particelle sono sia distruttibili sia
indistruttibili, dove la materia è sia
continua sia discontinua e dove forza e materia sono soltanto aspetti diversi
dello stesso fenomeno. In tutti questi esempi, che verranno esaminati
ampiamente nei prossimi capitoli, risulta che lo schema dell'opposizione dei
concetti, derivata dalla nostra esperienza quotidiana, è troppo ristretto per
il mondo delle particelle subatomiche.
La
teoria della relatività è fondamentale per la descrizione di questo mondo e nel
contesto «relativistico» i concetti classici sono superati nel passaggio a un
numero superiore di dimensioni, lo spazio-tempo quadridimensionale. Gli stessi
concetti di spazio e di tempo, che erano sembrati completamente distinti, sono
stati unificati nella fisica relativistica. Su questa unità fondamentale si
basa l'unificazione dei concetti opposti ricordata sopra. Come avviene per
l'unità degli opposti di cui fanno esperienza i mistici, essa si verifica ad un
«livello superiore», cioè con una ulteriore dimensione, e si presenta come una
unità dinamica, perché lo spazio-tempo relativistico è una realtà
intrinsecamente dinamica nella quale gli oggetti sono anche processi e tutte le
forme sono configurazioni dinamiche.
Per
rendersi conto di come si realizza l'unificazione di entità apparentemente
separate quando si aggiunge un'ulteriore dimensione non è strettamente
necessaria la teoria della relatività, in quanto tale unificazione può anche
essere sperimentata passando da una a due dimensioni, oppure da due a tre.
Nell'esempio precedente del moto circolare e della sua proiezione, i poli
opposti dell'oscillazione in una dimensione (lungo una linea) sono unificati
nel moto circolare in due dimensioni (su un piano). Il disegno rappresenta un
altro esempio, che comporta il passaggio da due a tre dimensioni. Esso mostra
un anello a forma di «ciambella» tagliato orizzontalmente da un piano. Nelle
due dimensioni di quel piano, la sezione appare composta da due dischi
completamente separati, ma in tre dimensioni questi dischi appaiono come parti
di un unico oggetto. In modo analogo, entità che sembrano separate e non
conciliabili vengono unificate, nella teoria della relatività, col passaggio da
tre a quattro dimensioni. Il mondo quadridimensionale della teoria della
relatività è il mondo nel quale forza e materia sono unificate; in esso la
materia può apparire sotto forma di particelle discontinue o come campo
continuo. In questi casi, tuttavia, non possiamo più visualizzare efficacemente
tale unità. I fisici possono «fare esperienza» del mondo quadridimensionale
dello spazio-tempo attraverso il formalismo matematico astratto delle loro
teorie, ma la loro immaginazione visiva - come quella di qualsiasi altra persona - è
limitata al mondo tridimensionale dei sensi. Gli schemi del nostro linguaggio e
del nostro pensiero si sono sviluppati in questo mondo tridimensionale e perciò
troviamo estremamente difficile trattare la realtà quadridimensionale della
fisica relativistica.
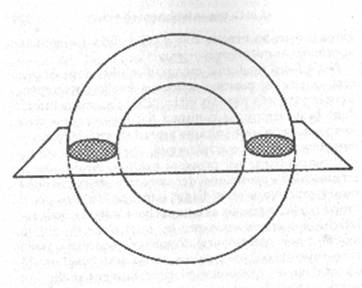
ESPERIENZA DELLA REALTÀ
MULTIDIMENSIONALE
I
mistici orientali, d'altra parte, sembrano in grado di percepire direttamente e
concretamente una realtà multidimensionale. Nello
stato di profonda meditazione essi trascendono il mondo tridimensionale della
vita quotidiana e avvertono una realtà completamente diversa, nella quale gli
opposti sono unificati in un tutto organico. Quando i mistici tentano di
esprimere questa esperienza con parole, si trovano di fronte agli stessi
problemi dei fisici che tentano di interpretare la realtà multidimensionale
della fisica relativistica. Ecco come si esprime il Lama Govinda:
« ... si raggiunge
un'esperienza di dimensionalità superiore attraverso
l'integrazione delle esperienze di centri e di livelli di coscienza diversi. Di
qui l'indescrivibilità di certe esperienze di meditazione sul piano della
coscienza tridimensionale e nell'ambito di un sistema di ragionamento che
riduce le possibilità di espressione, imponendo ulteriori limiti al processo
del pensiero».
ONDA E PARTICELLA
Il mondo
quadridimensionale della teoria della relatività non è l'unica situazione della
fisica moderna nella quale concetti apparentemente contraddittori e
inconciliabili si rivelano nient'altro che differenti aspetti della stessa
realtà. Forse il caso più noto di tale unificazione di concetti contraddittori
è quello dei concetti di particella e di onda nella fisica atomica.
A
livello atomico, la materia ha un aspetto duale: si manifesta come particella e
come onda. L'aspetto che essa presenta dipende dalla situazione: in alcuni casi
predomina l'aspetto corpuscolare, in altri quello ondulatorio; e questa natura
duale è tipica anche della luce e di tutte le altre radiazioni
elettromagnetiche. La luce, per esempio, è emessa e assorbita sotto forma di
«quanti», o fotoni, ma quando viaggiano attraverso lo spazio queste particelle
di luce appaiono come campi elettrici e magnetici variabili che presentano
tutti i comportamenti caratteristici delle onde. Normalmente, gli elettroni
sono considerati particelle, eppure quando un fascio di queste particelle viene
fatto passare attraverso una fenditura sottile esso viene diffratto
proprio come un raggio di luce; in altre parole, anche gli elettroni si
comportano come onde.
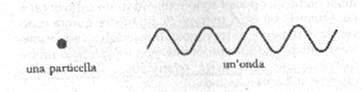
Questo
aspetto duale della materia e della radiazione è in effetti estremamente
sconcertante e ha dato origine a molti dei «koan
quantistici» che hanno portato alla formulazione della teoria dei quanti. La
rappresentazione di un'onda che è sempre estesa nello spazio è fondamentalmente
diversa da quella di una particella che implica una posizione precisa. Ci volle
molto tempo perché i fisici accettassero il fatto che la materia si manifesta
in modi che sembrano escludersi a vicenda: che le particelle sono anche onde e
le onde sono anche particelle.
Esaminando
i due disegni, un profano potrebbe forse pensare che sia possibile risolvere la
contraddizione dicendo che il disegno a destra rappresenta semplicemente una
particella che si muove seguendo una forma d'onda. Tuttavia, questa
considerazione nasce dall'aver frainteso il concetto di onda. In natura non
esistono particelle che si muovono seguendo forme d'onda. In un'onda
sull'acqua, per esempio, le particelle d'acqua non si spostano con l'onda ma si
muovono circolarmente mentre l'onda si propaga. Analogamente, le particelle
d'aria in un'onda acustica oscillano soltanto avanti e indietro, ma non si
propagano insieme con l'onda. Ciò che viene trasportato dall'onda è la
perturbazione che provoca il fenomeno ondulatorio, ma non particelle materiali.
Nella meccanica quantistica, perciò, non ci riferiamo alla traiettoria di una
particella quando diciamo che la particella è anche un'onda. Ciò che intendiamo
è che la forma d'onda nel suo insieme è una manifestazione della particella. La
rappresentazione di onde che si propagano è quindi totalmente diversa da quella
di particelle in moto; tanto differente, per usare le parole di Victor Weisskopf, «quanto l'idea di onde in un lago rispetto a
quella di un banco di pesci che nuotano nella stessa direzione».
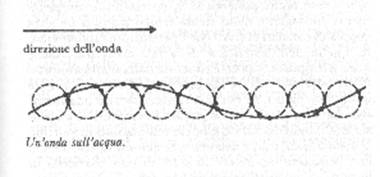
I
fenomeni ondulatori si incontrano in tutta la fisica in un gran numero di
situazioni diverse, e in ciascun caso possono essere descritti con il medesimo
formalismo matematico. Si usano le stesse espressioni matematiche per
descrivere un'onda luminosa, una corda di chitarra che vibra, un'onda acustica,
o un'onda sull'acqua. Nella meccanica quantistica, queste stesse espressioni
vengono usate per descrivere le onde associate alle particelle; in questo caso,
tuttavia, le onde sono molto più astratte. Esse sono strettamente legate alla
natura statistica della meccanica quantistica, cioè al fatto che i fenomeni
atomici possono essere descritti solo in termini di probabilità. L'informazione
sulle probabilità di una particella è contenuta in una quantità chiamata
funzione di probabilità e la forma matematica di questa quantità è quella di
un'onda, cioè essa è simile alle espressioni usate per la descrizione di altri
tipi di onde. Le onde associate alle particelle, tuttavia, non sono onde
tridimensionali reali», come le onde sull'acqua o le onde acustiche, ma sono «onde
di probabilità», quantità matematiche astratte legate alle probabilità
di trovare le particelle in vari punti e con varie proprietà.
L'introduzione
delle onde di probabilità risolve, in un certo senso, il paradosso delle
particelle che si comportano come onde, ponendolo in un contesto completamente
nuovo, ma nello stesso tempo porta a un'altra coppia di concetti opposti che è
persino più fondamentale, quella dell'esistenza e della non-esistenza. Anche
questa coppia di opposti è superata dalla realtà atomica. Non possiamo mai dire
che una particella atomica esiste in un dato punto, né che non esiste. Essendo
una distribuzione di probabilità, la particella ha tendenza a esistere in
luoghi diversi e quindi manifesta uno strano tipo di realtà fisica tra
l'esistenza e la non-esistenza. Perciò non possiamo descrivere lo stato di una
particella in termini di concetti rigidamente opposti. In un dato punto, la
particella non è né presente, né assente; non cambia la sua posizione, ma
nemmeno rimane in quiete. Ciò che muta è la distribuzione di probabilità e
quindi la tendenza della particella ad esistere in dati luoghi. Per usare le
parole di Robert Oppenheimer:
«Per esempio, alla
domanda se la posizione dell'elettrone resti sempre la stessa, dobbiamo
rispondere "no"; alla domanda se la posizione dell'elettrone cambi
col passare del tempo, dobbiamo rispondere "no"; alla domanda se esso
sia fermo, dobbiamo rispondere "no"; alla domanda se esso sia in
movimento, dobbiamo rispondere "no"».
La
realtà del fisico atomico, come la realtà del mistico orientale, trascende lo
schema ristretto dei concetti opposti. Perciò le parole di Oppenheimer
ci sembrano riecheggiare quelle delle Upanişad:
«Costui si muove,
Costui non si muove; Costui è lontano, Costui è vicino; Costui è all'interno di
questo Tutto, Costui è anche all'esterno di questo Tutto».
ESISTENZA E NON ESISTENZA
Forza e
materia, particelle e onde, movimento e quiete, esistenza e non-esistenza:
questi sono alcuni dei concetti opposti o contraddittori che sono stati
superati nella fisica moderna. Di tutte queste coppie di opposti, l'ultima
sembra essere la più fondamentale, eppure nella fisica atomica dobbiamo andare
addirittura al di là dei concetti di esistenza e di non-esistenza. Questo è
l'aspetto della meccanica quantistica più difficile da accettare e che sta al
centro della continua discussione sulla sua interpretazione. Nello stesso
tempo, il superamento dei concetti di esistenza e di non-esistenza è anche uno
degli aspetti più sconcertanti del misticismo orientale.
Come i fisici
atomici, i mistici orientali si occupano di una realtà che si trova al di là
dell'esistenza e della non-esistenza, ed essi mettono frequentemente in risalto
questo fatto importante. Così si esprime Aśvaghosa:
«L'essenza assoluta non è né ciò che è
esistenza, né ciò che è non-esistenza, né ciò che è a un tempo esistenza e
non-esistenza, né ciò che non è a un tempo esistenza e non-esistenza».
Posti di
fronte a una realtà che giace al di là della opposizione dei concetti, i fisici
e i mistici devono adottare un modo di pensare particolare, nel quale la mente
non si fissa nello schema rigido della logica classica, ma continua a muoversi
e spostare il suo punto di vista. Nella fisica atomica, per esempio,
attualmente siamo abituati a usare sia il concetto di particella sia quello di
onda nella nostra descrizione della materia. Abbiamo imparato a destreggiarci
con queste due rappresentazioni, passando dall'una all'altra e viceversa, per
essere all'altezza della realtà atomica. Questo è precisamente il modo di
procedere dei mistici orientali quando cercano di interpretare la loro
esperienza di una realtà al di là degli opposti.
Come
dice il Lama Govinda, «il modo orientale di pensare
consiste soprattutto nel girare intorno all'oggetto della contemplazione...
un'impressione sfaccettata, cioè pluridimensionale che si forma dalla
sovrapposizione di singole impressioni ottenute da punti di vista differenti».
Per
vedere come in fisica atomica si possa passare dalla rappresentazione
corpuscolare a quella ondulatoria e viceversa, esaminiamo più dettagliatamente
i concetti di onda e di particella. Un'onda è una forma che vibra nello spazio
e nel tempo. Possiamo osservarla in un dato istante di tempo e allora vediamo
una figura periodica nello spazio, come nell'esempio seguente:
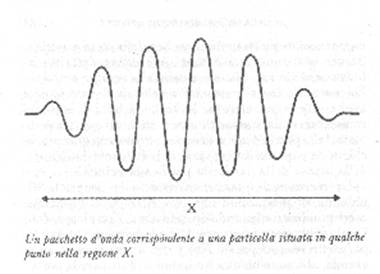
Questa
forma d'onda è caratterizzata dall'ampiezza A, l'estensione della vibrazione, e
dalla lunghezza d'onda L, la distanza tra due creste successive. In
alternativa, possiamo invece osservare il moto di un punto definito dell'onda e
vedremo allora un'oscillazione caratterizzata da una certa frequenza, cioè dal
numero di volte che il punto oscilla su e giù in un secondo. Esaminiamo ora il
concetto di particella. Secondo le idee classiche, una particella ha una
posizione ben definita in qualsiasi istante, e il suo stato di moto può essere
descritto in funzione della sua velocità e della sua energia cinetica. Le
particelle che si muovono a velocità elevate hanno anche un'energia elevata. In
realtà, i fisici si servono raramente della «velocità» per descrivere lo stato
di moto della particella, ma usano piuttosto una grandezza chiamata «quantità
di moto», definita come il prodotto della massa della particella per la sua
velocità.
La
meccanica quantistica associa le proprietà di un'onda di probabilità alle
proprietà della particella corrispondente mettendo in relazione l'ampiezza
dell'onda in un dato punto con la probabilità di trovare la particella in quel
punto. Nei punti in cui l'ampiezza è grande, abbiamo un'alta probabilità di
trovare la particella e dove l'ampiezza è piccola, anche la probabilità è
piccola. Per esempio, l'onda della figura precedente ha la stessa ampiezza
lungo tutta la sua lunghezza (si deve pensare che il disegno si prolunghi
indefinitamente sia a destra che a sinistra) e quindi la particella si può
trovare dovunque lungo l'onda con la stessa probabilità. (1)
L'informazione sullo stato di
moto della particella è contenuta nella lunghezza d'onda e nella frequenza
dell'onda. La
lunghezza d'onda è inversamente proporzionale alla quantità di moto della
particella, il che significa che un'onda con piccola lunghezza d'onda
corrisponde a una particella che si muove con una grande quantità di moto (e
quindi con elevata velocità). La frequenza dell'onda è proporzionale
all'energia della particella; un'onda con frequenza elevata indica che la
particella ha grande energia. Nel caso della luce, per esempio, la luce viola
ha un'alta frequenza e una piccola lunghezza d'onda e perciò è formata da
fotoni con elevata energia ed elevata quantità di moto, mentre la luce rossa ha
bassa frequenza e grande lunghezza d'onda, che corrispondono a fotoni di bassa
energia e bassa quantità di moto.
foto
Un'onda
estesa come quella del nostro esempio non ci dice molto riguardo alla posizione
della particella corrispondente. Essa si può trovare dovunque lungo l'onda con
la stessa probabilità. Molto spesso, tuttavia, abbiamo a che fare con
situazioni in cui la posizione della particella è nota con una certa
precisione, per esempio nella descrizione di un elettrone in un atomo. In tal
caso, le probabilità di trovare la particella in vari punti devono essere
confinate in una data regione di spazio. Al di fuori di questa regione le
probabilità devono essere nulle. Ciò può essere ottenuto con una forma d'onda
come quella del disegno che corrisponde a .una particella confinata nella
regione X. Una figura di questo tipo viene chiamata pacchetto d'onda.' Essa è composta da molti treni d'onda indefinitamente
estesi, con diverse lunghezze d'onda, che interferiscono l'uno con l'altro distruttivamente' al di fuori della regione X, cosicché
l'ampiezza totale - e quindi la probabilità di trovare lì la particella - è
zero, mentre invece dentro la regione X interferiscono in modo da formare la
figura rappresentata nel disegno. Questa figura fa vedere che la particella si
trova in qualche punto interno alla regione X, ma non ci permette di
localizzarla ulteriormente. Per i punti interni alla regione X possiamo solo
assegnare le probabilità per la presenza della particella. (È più probabile che
la particella si trovi nella zona centrale, dove le ampiezze di probabilità
sono grandi, e meno probabile che si trovi verso gli estremi del pacchetto
d'onda, dove le ampiezze sono piccole). La lunghezza del pacchetto d'onda
rappresenta quindi l'incertezza nella posizione della particella.
La
proprietà importante di un pacchetto d'onda del genere è che esso non ha una
lunghezza d'onda definita, cioè le distanze tra due creste successive non sono
uguali lungo tutta la figura. C'è una dispersione in lunghezza d'onda che
dipende dalla lunghezza del pacchetto d'onda; più è corto il pacchetto, più
ampia è la dispersione. Ciò non ha nulla a che fare con la meccanica
quantistica, ma deriva semplicemente dalle proprietà delle onde. I pacchetti
d'onda non hanno una lunghezza d'onda definita. La meccanica quantistica entra
in gioco quando associamo la lunghezza d'onda alla quantità di moto della
particella corrispondente. Se il pacchetto d'onda non ha una lunghezza d'onda
ben definita, la particella non ha una quantità di moto ben definita. Ciò
significa che non solo c'è una incertezza nella posizione della particella, che
corrisponde alla lunghezza del pacchetto d'onda, ma c'è anche una incertezza
nella sua quantità di moto, prodotta dalla dispersione in lunghezza d'onda.
Queste due incertezze sono interdipendenti, perché la dispersione in lunghezza
d'onda (cioè l'incertezza della quantità di moto) dipende dalla lunghezza del
pacchetto d'onda (cioè dall'incertezza della posizione). Se vogliamo
localizzare la particella con maggiore precisione, cioè se vogliamo confinare
il pacchetto d'onda in una regione più piccola, ciò porta a un aumento della
dispersione in lunghezza d'onda e quindi a un aumento nell'incertezza della
quantità di moto della particella.
La forma
matematica precisa di questa relazione tra le incertezze nella posizione e
nella quantità di moto di una particella è nota come principio di
indeterminazione di Heisenberg. Esso indica che, nel
mondo subatomico, non possiamo mai conoscere contemporaneamente la posizione e
la quantità di moto di una particella con grandissima precisione. Quanto meglio
conosciamo la posizione, tanto più incerta diventa la quantità di moto, e
viceversa. Possiamo decidere di effettuare una misura precisa di una delle due
quantità, ma allora resteremo completamente all'oscuro dell'altra. È importante
comprendere, come è stato già posto in evidenza nel capitolo precedente, che
questa non è una limitazione dovuta all'imperfezione delle nostre tecniche di
misura, ma è una limitazione di principio. Se decidiamo di misurare con
precisione la posizione della particella, essa semplicemente non ha una
quantità di moto ben definita, e viceversa.
La
relazione tra le incertezze nella posizione e nella quantità di moto della
particella non è l'unica forma in cui si può esprimere il principio di
indeterminazione. Analoghe relazioni valgono fra altre quantità, per esempio
tra l'intervallo di tempo in cui avviene un processo atomico e l'energia in
esso coinvolta. Ciò può essere visualizzato abbastanza facilmente
rappresentando il nostro pacchetto d'onda non come una forma nello spazio, ma
come una forma che vibra nel tempo. Quando la particella passa per un
particolare punto di osservazione, le vibrazioni della forma d'onda in quel
punto inizieranno con piccole ampiezze che aumenteranno e poi diminuiranno
nuovamente fino a quando la vibrazione cesserà completamente. Il tempo
impiegato dal passaggio di questa forma d'onda rappresenta l'intervallo durante
il quale la particella attraversa il nostro punto di osservazione. Possiamo
dire che il passaggio avviene in questo intervallo di tempo, ma non possiamo
precisarlo ulteriormente. La durata del passaggio della vibrazione rappresenta
quindi l'incertezza nella posizione temporale dell'evento.
Ora,
come la forma spaziale del pacchetto d'onda non ha una lunghezza d'onda ben
definita, la corrispondente oscillazione che vibra nel tempo non ha una
frequenza ben definita. La dispersione in frequenza dipende dalla durata della
forma d'onda e poiché la teoria quantistica associa la frequenza dell'onda
all'energia della particella, la dispersione in frequenza corrisponde a una
incertezza nell'energia della particella. L'incertezza nella posizione di un
evento nel tempo risulta quindi collegata a una incertezza nell'energia allo
stesso modo in cui una incertezza nella posizione di una particella nello
spazio è collegata a una incertezza nella quantità di moto. Ciò significa che
non possiamo mai conoscere con grande precisione sia l'istante nel quale
avviene un evento sia l'energia in esso coinvolta. Eventi che avvengono entro
un breve intervallo di tempo comportano una grande incertezza nell'energia;
eventi che comportano una precisa quantità di energia possono essere
individuati solo all'interno di un lungo intervallo di tempo.
L'importanza
fondamentale del principio di indeterminazione consiste nel fatto che esso
esprime i limiti dei nostri concetti classici in una precisa forma matematica.
Abbiamo già osservato precedentemente che il mondo subatomico appare come una
rete di relazioni tra le varie parti di un tutto unico. I nostri concetti
classici, derivati dall'ordinaria esperienza macroscopica, non sono del tutto
adeguati a descrivere questo mondo. Anzitutto, il concetto di una entità fisica
distinta quale la particella è un'idealizzazione che non ha alcun significato
fondamentale. Essa può essere definita solo in rapporto alle sue connessioni
con il tutto, e queste connessioni sono di natura statistica: probabilità
invece di certezze. Quando descriviamo le proprietà di un'entità di questo tipo
in termini di concetti classici - come posizione, energia, quantità di moto,
ecc. - troviamo che esistono coppie di concetti che sono in relazione tra di
loro e che non possono essere definiti simultaneamente in modo preciso. Più
forziamo uno dei concetti sull'oggetto fisico, più l'altro concetto diventa
indeterminato, e la precisa relazione tra i due è espressa dal principio di
indeterminazione.
Per permettere
una migliore comprensione di questa relazione tra coppie di concetti classici, Niels Bohr ha introdotto l'idea
di complementarità. Egli considerò la rappresentazione corpuscolare e quella
ondulatoria come due descrizioni complementari della stessa realtà, ciascuna
delle quali è solo parzialmente adeguata e con un limitato campo di
applicazione. Ognuna delle due rappresentazioni è necessaria per dare una
descrizione completa della realtà atomica, ed entrambe devono essere applicate
entro i limiti fissati dal principio di indeterminazione.
Questa
idea di complementarità è diventata un aspetto essenziale del modo col quale i
fisici riflettono sulla natura e Bohr ha spesso
suggerito che potrebbe essere un concetto utile anche fuori della fisica; in effetti
la nozione di complementarità si è dimostrata estremamente utile
duemilacinquecento anni fa.
Essa
svolse un ruolo essenziale nel pensiero cinese antico che era basato
sull'intuizione secondo la quale i concetti opposti stanno in rapporto polare,
o complementare, l'uno rispetto all'altro. I saggi cinesi rappresentavano
questa complementarità degli opposti con gli archetipi polari yin e yang e consideravano la
loro interazione dinamica come l'essenza di tutti i fenomeni naturali e di
tutte le situazioni umane.
Niels Bohr fu ben consapevole della
corrispondenza tra il suo concetto di complementarità e il pensiero cinese.
Durante una sua visita in Cina, nel 1937, quando la sua interpretazione della
meccanica quantistica era già stata completamente elaborata, egli fu
profondamente colpito dall'antica idea cinese di opposti polari, e da allora
conservò un profondo interesse per la cultura orientale.
Dieci
anni più tardi Bohr fu fatto nobile in riconoscimento
dei suoi notevoli risultati scientifici e per gli importanti contributi alla
vita culturale danese; e quando gli fu chiesto di scegliere un soggetto adatto
al suo stemma, la sua scelta cadde sul simbolo cinese del T'ai Chi che
rappresenta la relazione di complementarità degli archetipi opposti yin e yang. Scegliendo questo simbolo per il suo stemma assieme al motto Contraria sunt
complemento (gli opposti sono complementari), Niels
Bohr riconobbe una profonda armonia tra l'antica
saggezza orientale e la scienza occidentale moderna.
|
|
Altri argomenti
del Tao
© www.mimmademaio.com - 2012
|
|