VUOTO
E FORMA
IL CAMBIAMENTO
DELLA FISICA MODERNA
La concezione
meccanicistica classica del mondo era basata sull'idea di particelle solide e
indistruttibili che si muovono nel vuoto. La fisica moderna ha prodotto un cambiamento
radicale di questa immagine, giungendo non solo a una nozione completamente
nuova di “particella”, ma trasformando anche profondamente il concetto classico
di vuoto. Questa trasformazione, che si realizzò nelle cosiddette teorie dei
campi, ebbe inizio con l'idea einsteiniana di
associare il campo gravitazionale alla geometria dello spazio, e divenne ancora
più profonda quando la teoria dei quanti e la teoria della relatività furono
unite per descrivere i campi di forza delle particelle subatomiche. In queste
“teorie quantistiche dei campi”, la distinzione tra le particelle e lo spazio
che le circonda diviene sempre più sfumata e il vuoto è concepito come una
entità dinamica di importanza fondamentale.
IL CONCETTO DI
CAMPO
Il concetto di
campo venne introdotto nel diciannovesimo secolo da Faraday e da Maxwell nella
loro descrizione delle forze tra cariche elettriche e correnti. Un campo
elettrico è una condizione, nello spazio attorno a un corpo carico, che può
produrre una forza su una qualsiasi altra carica posta in quello spazio. I
campi elettrici sono quindi creati da corpi carichi e i loro effetti possono
essere risentiti solo da altri corpi carichi. I campi magnetici sono prodotti
da cariche in moto, cioè da correnti elettriche, e le forze magnetiche da essi
generate possono essere risentite da altre cariche in moto.
Nell'elettrodinamica classica, cioè nella teoria costruita da Faraday e da Maxwell, i campi
sono entità fisiche primarie che possono essere studiate senza fare alcun
riferimento a corpi materiali. I campi elettrici e magnetici variabili possono
propagarsi attraverso lo spazio sotto forma di onde radio, di onde luminose, o
di altri tipi di radiazione elettromagnetica.
La teoria della
relatività ha reso molto più elegante la struttura dell'elettrodinamica
unificando i concetti di carica e di corrente da una parte, di campo elettrico
e di campo magnetico dall'altra. Dato che ogni moto è relativo, ogni carica può
apparire anche come corrente – in un
sistema di riferimento in cui essa si muove rispetto all'osservatore – e di conseguenza il suo campo elettrico può
anche manifestarsi come campo magnetico. Nella formulazione relativistica della elettrodinamica, i due campi sono così
unificati in un unico campo elettromagnetico.
LA FORZA DI GRAVITÀ
Il concetto di
campo è stato associato non solo alla forza elettromagnetica, ma anche
all'altra forza fondamentale presente su larga scala nell'universo, la forza di
gravità. I campi gravitazionali sono creati e risentiti da tutte le masse, e le
forze che ne derivano sono sempre attrattive, a differenza dei campi
elettromagnetici che sono risentiti solo dai corpi carichi e danno luogo a
forze sia attrattive che repulsive. La teoria dei campi adatta per il campo
gravitazionale è la teoria generale della relatività; in essa l'influenza di
una massa sullo spazio circostante ha una portata più vasta di quanto non lo
sia la corrispondente influenza di un corpo carico in elettrodinamica. Anche
qui lo spazio attorno all'oggetto è “condizionato” in modo tale che un altro
oggetto può risentire una forza, ma questa volta il condizionamento modifica la
geometria, e quindi la struttura stessa dello spazio.
IL PIENO E IL VUOTO
Materia e spazio
vuoto – il pieno e il vuoto – furono i due concetti, fondamentalmente distinti,
sui quali si basò l'atomismo di Democrito
e di Newton. Nella relatività generale, questi due concetti non possono più
rimanere separati. Ovunque è presente una massa, sarà presente anche un campo
gravitazionale, e questo campo si manifesterà come una curvatura dello spazio
che circonda quella massa. Non dobbiamo pensare, tuttavia, che il campo riempia
lo spazio e lo “incurvi”. Il campo e lo spazio non possono essere distinti: il
campo è lo spazio curvo! Nella relatività generale, il campo gravitazionale e
la struttura, o geometria, dello spazio sono identici. Essi sono rappresentati
nelle equazioni del campo di Einstein dalla medesima
grandezza matematica. Nella teoria di Einstein,
quindi, la materia non può essere separata dal suo campo di gravità, e il campo
di gravità non può essere separato dallo spazio curvo. Materia e spazio sono
pertanto visti come parti inseparabili e interdipendenti di un tutto unico.
GLI OGGETTI
MATERIALI LEGATI ALL’AMBIENTE
Gli oggetti
materiali non solo determinano la struttura dello spazio circostante, ma a loro
volta sono influenzati in modo sostanziale dall'ambiente. Secondo il fisico e
filosofo Ernst Mach, l'inerzia di un oggetto
materiale – la resistenza che oppone ad
essere accelerato – non è una proprietà
intrinseca alla materia, ma una misura della sua interazione con tutto il resto
dell'universo. Nella concezione di Mach, la materia possiede inerzia solo
perché esiste altra materia nell'universo. Quando un corpo ruota, la sua
inerzia produce le forze centrifughe (utilizzate, per esempio, nella fase di
centrifugazione di una lavatrice per togliere l'acqua dal bucato bagnato), ma
queste forze compaiono solo perché il corpo ruota “rispetto alle stelle fisse”,
come ha fatto notare Mach. Se queste stelle fisse dovessero improvvisamente
scomparire, l'inerzia e le forze centrifughe del corpo rotante scomparirebbero
con esse.
Questa concezione
dell'inerzia, nota come principio di Mach, ebbe una profonda influenza su Albert Einstein e costituì la motivazione
iniziale che lo stimolò a costruire la teoria generale della relatività. A
causa della considerevole complessità matematica della teoria di Einstein, finora i fisici non sono riusciti a stabilire
concordemente se essa incorpora realmente il principio di Mach o no. La maggior parte dei fisici ritiene, tuttavia, che
questo principio dovrebbe essere incorporato, in qualche modo, in una teoria
completa della gravità.
Quindi la fisica
moderna ci mostra di nuovo – e questa volta a un livello macroscopico – che gli
oggetti materiali non sono entità distinte, ma sono legati in maniera
inseparabile al loro ambiente; e che le loro proprietà possono essere comprese
solo nei termini della loro interazione con il resto del mondo. Secondo il
principio di Mach, questa interazione si estende all'universo in generale, alle
stelle e alle galassie lontane. L'unità fondamentale del cosmo si manifesta,
perciò, non solo nel mondo dell'infinitamente piccolo ma anche nel mondo
dell'infinitamente grande; un fatto che è sempre più accettato nell'astrofisica
e nella cosmologia moderne. Per usare le parole dell'astronomo Fred Hoyle,
«Gli odierni progressi della
cosmologia indicano piuttosto insistentemente che le condizioni della nostra
esistenza quotidiana non potrebbero sussistere se non fosse per le parti remote
dell'Universo, che tutti i nostri concetti dello spazio e della geometria
sarebbero completamente invalidati se le parti remote dell'Universo dovessero
scomparire. La nostra esperienza quotidiana, fino ai minimi particolari, sembra
essere così strettamente integrata negli aspetti su vasta scala dell'Universo,
che è assolutamente impossibile pensare a una separazione delle due cose».
IL LIVELLO
SUBATOMICO
L'unità e il
rapporto reciproco tra un oggetto materiale e il suo ambiente, che è evidente
su scala macroscopica nella teoria generale della relatività, appare in una
forma ancora più sorprendente a livello subatomico. Qui, le idee della teoria
classica del campo si combinano con quelle della meccanica quantistica per
descrivere le interazioni tra particelle subatomiche. Una combinazione di
questo tipo non è stata finora possibile per l'interazione gravitazionale a
causa della complicata forma matematica della teoria della relatività di Einstein; ma l'altra teoria classica del campo,
l'elettrodinamica, è stata fusa con la meccanica quantistica in una teoria
chiamata «elettrodinamica quantistica» che descrive tutte le interazioni
elettromagnetiche tra particelle subatomiche. Questa teoria incorpora sia la
teoria quantistica sia quella relativistica. Essa fu il primo modello «quantistico-relativistico» della fisica moderna ed è, a tutt'oggi, quello meglio riuscito.
La caratteristica
nuova e sorprendente dell'elettrodinamica quantistica deriva dalla combinazione
di due concetti: quello di campo elettromagnetico e quello di fotoni intesi
come manifestazione corpuscolare delle onde elettromagnetiche. Poiché i fotoni
sono anche onde elettromagnetiche, e poiché queste onde sono campi variabili, i
fotoni devono essere manifestazioni dei campi elettromagnetici. Di qui il
concetto di «campo quantistico», cioè di un campo che può assumere la forma di
quanti, o particelle. Il campo quantistico è un concetto completamente nuovo
che è stato esteso ed applicato alla descrizione di tutte le particelle
subatomiche e delle loro interazioni, facendo corrispondere a ciascun tipo di
particella un diverso tipo di campo. In queste «teorie quantistiche dei campi»,
il contrasto della teoria classica tra le particelle solide e lo spazio circostante
è completamente superato. Il campo quantistico è visto come l'entità fisica
fondamentale: un mezzo continuo presente ovunque nello spazio. Le particelle
sono soltanto condensazioni locali del campo, concentrazioni di energia
che vanno e vengono e di conseguenza perdono il loro carattere individuale e si
dissolvono nel campo soggiacente ad esse. Come dice Albert
Einstein:
“Noi possiamo perciò considerare
la materia come costituita dalle regioni dello spazio nelle quali il campo è
estremamente intenso... In questo nuovo tipo di fisica non c'è luogo insieme
per campo e materia poiché il campo è la sola realtà”.
LA CONCEZIONE
ORIENTALE DEL MONDO
La concezione delle
cose e dei fenomeni fisici come manifestazioni effimere di una entità
fondamentale soggiacente non è solo un elemento di fondo della teoria dei
campi, ma anche un elemento basilare della concezione orientale del mondo. Come
Einstein, i mistici orientali considerano questa
entità soggiacente come la sola realtà: tutte le sue manifestazioni fenomeniche
sono viste come transitorie e illusorie. Questa realtà del mistico orientale
non può essere identificata con il campo quantistico dei fisici, poiché essa è
vista come l'essenza di tutti i fenomeni di questo mondo e, di conseguenza, è
al di là di tutti i concetti E di tutte le idee. Il campo quantistico,
viceversa, è un concetto ben definito che spiega solo alcuni dei fenomeni
fisici. Ciononostante, l'intuizione che sta dietro l'interpretazione che i
fisici danno del mondo subatomico, in termini di campo quantistico, ha una
stretta analogia con quella del mistico orientale che interpreta la propria
esperienza del mondo sulla base di una realtà ultima fondamentale. Dopo che era
stato introdotto il concetto di campo, i fisici hanno tentato di unificare i
vari campi in un unico campo fondamentale che dovrebbe incorporare tutti i
fenomeni fisici. Einstein, in particolare, dedicò gli
ultimi anni della sua vita alla ricerca di questo campo unificato. Il Brahman degli Indù, il Dharrnakāya
dei Buddhisti e il Tao dei Taoisti
possono essere visti, forse, come il campo unificato fondamentale da cui
nascono non solo i fenomeni studiati in fisica, ma anche tutti gli altri
fenomeni.
Nella concezione
orientale, la realtà soggiacente a tutti i fenomeni trascende tutte le forme e
sfugge a tutte le descrizioni e specificazioni. Di essa, perciò, si dice spesso
che è senza forme, vacua e vuota. Ma questa vacuità non dev'essere
presa per semplice non-essere. Essa è, al contrario, l'essenza di tutte le
forme e la sorgente di tutta la vita. Si legge infatti nelle Upanisad:
“Il Brahman
è il soffio vitale, il Brahman è ka
[felicità], il Brahman kha
[spazio etereo]... Ciò che è ka è anche kha, ciò che è kha è anche ka”.
I Buddhisti esprimono la stessa idea quando essi chiamano la
realtà ultima Śūnyata
- «vacuità» o «vuoto» - e affermano che è un vuoto vivo che dà origine a tutte
le forme del mondo fenomenico. I Taoisti
attribuiscono un'analoga creatività, immensa e incessante, al Tao, e anch'essi lo indicano come vuoto.
«Il Tao dei cieli è vuoto e senza
forme» dice il Kuan-tzu , e Lao-tzu
usa diverse metafore per illustrare questa vacuità. Egli spesso paragona il Tao
a una valle profonda, oppure a un vaso eternamente vuoto e che quindi ha la
possibilità di contenere un'infinità di cose.
Nonostante l'uso di
termini come vacuità e vuoto, i saggi orientali fanno capire che essi non
intendono la normale vacuità quando parlano del Brahman,
del Śūnyata o del Tao, ma, al contrario,
intendono un vuoto che ha un potenziale creativo infinito. Dunque, il vuoto dei
mistici orientali è certamente paragonabile al campo quantistico della fisica
subatomica. Come il campo quantistico, esso genera una infinita varietà di
forme che sostiene e, alla fine, riassorbe. Come dicono le Upanisad,
In calma, adori Lui
da cui è venuto
in cui si dissolverà
in cui oggi respira.
Le manifestazioni
fenomeniche del Vuoto mistico, come le particelle subatomiche, non sono statiche
e permanenti, ma dinamiche e transitorie; entrano nell'esistenza e svaniscono
in una incessante danza di movimento e di energia. Come il mondo subatomico dei
fisici, il mondo fenomenico del mistico orientale è un mondo di samsāra, di continua nascita e morte. Essendo
manifestazioni effimere del Vuoto, le cose in questo mondo non hanno alcuna
identità fondamentale. Ciò è messo in evidenza soprattutto nella filosofia buddhista, la quale nega l'esistenza di qualsiasi sostanza
materiale e sostiene anche che l'idea di un «sé» costante che passa attraverso
successive esperienze è un'illusione. I Buddhisti
hanno spesso paragonato questa illusione di una sostanza materiale e di un sé
individuale al fenomeno di un'onda sull'acqua, nel quale il movimento in su e in
giù delle particelle d'acqua ci fa credere che una «parte» di essa si muova
sulla superficie. È interessante notare che i fisici hanno usato la stessa
analogia nel contesto della teoria dei campi per mettere in evidenza
l'illusione creata da una particella in moto dell'esistenza di una sostanza
materiale.
Hermann Weyl
per esempio scrive:
“Secondo questa teoria [la teoria
della materia come campo] una particella elementare, per esempio un elettrone,
è soltanto una piccola regione del campo elettrico in cui l'intensità assume
valori estremamente alti, a indicare che una porzione relativamente enorme
dell'energia del campo è concentrata in un piccolissimo spazio. Tale nodo di
energia, che non è affatto nettamente distinto dal resto del campo, si propaga
attraverso lo spazio vuoto come un'onda sulla superficie di un lago; non vi è
nulla che possa considerarsi come un'unica e stessa sostanza di cui l'elettrone
consista in ogni istante”.
Nella filosofia
cinese, l'idea di campo non solo è implicita nella nozione del Tao, vuoto e
senza forma e che tuttavia produce tutte le forme, ma è anche espressa
esplicitamente nel concetto di ch'i . Questo termine ebbe una funzione
importante in quasi tutte le scuole cinesi di filosofia naturale e fu particolarmente
importante nel Neoconfucianesimo, la scuola che tentò una sintesi di
Confucianesimo, Buddhismo e Taoismo. La parola ch'i
letteralmente significa «gas» o «etere», e fu usata nell'antica Cina per
indicare il soffio vitale, o energia vitale che anima il cosmo. Nel corpo
umano, i «canali del ch'i» sono la base della medicina cinese tradizionale. Lo
scopo dell'agopuntura è di stimolare il flusso del ch'i attraverso questi
canali. Il flusso del ch'i è anche la base dei movimenti sinuosi del T'ai Chi Ch'uan, la
danza taoista del guerriero.
I Neoconfuciani elaborarono un concetto di ch'i che somiglia
straordinariamente al concetto di campo quantistico della fisica moderna. Allo
stesso modo del campo quantistico, il ch'i è concepito come una forma di materia
tenue e non percettibile che è presente in tutto lo spazio e può condensarsi in
oggetti materiali solidi.
Dice Chang Tsai:
«Quando il ch'i si condensa ci
appare come cosa visibile e allora ci sono le forme [delle cose singole].
Quando si rarefà, la sua visibilità si annulla e
allora non ci sono forme. Durante la sua condensazione si può non dire che
questa è solo temporanea? ma quando si rarefà si può
dire affrettatamente che allora non esiste?».
Quindi il ch'i si
condensa e si rarefà ritmicamente,
producendo tutte le forme che alla fine si dissolvono nel Vuoto.
Dice ancora Chang Tsai:
«Il Grande Vuoto non può
consistere che nel ch'i; questo ch'i non può che condensarsi per dar forma a
tutte le cose; queste cose non possono che rarefarsi per dar luogo [ancora una
volta] al Grande Vuoto».
Come nella teoria
dei campi, il campo - ovvero il ch'i
- non solo è l'essenza soggiacente a
tutti gli oggetti materiali, ma trasporta anche le loro interazioni reciproche
sotto forma di onde. Dalle descrizioni che seguono, quella di Walter Thirring del concetto di campo nella fisica moderna, e
quella di Joseph Needham
della concezione cinese del mondo fisico, appare con chiarezza quanto le due
idee si somiglino.
“La fisica moderna... ha posto il
nostro pensiero circa l'essenza della materia in un contesto diverso. Essa ha
spostato la nostra attenzione dal visibile, le particelle, all'entità
soggiacente ad esse, il campo. La presenza di materia è solo una perturbazione
dello stato perfetto del campo in quel punto; si potrebbe quasi dire che è
qualcosa di accidentale, soltanto un "difetto". Di conseguenza, non
ci sono leggi semplici che descrivono le forze tra le particelle elementari...
Ordine e simmetria devono essere cercati nel campo soggiacente ad esse ».
«Nell'antichità e nel Medioevo, i
Cinesi concepivano l'universo fisico come un tutto perfettamente continuo. Il
ch'i condensato in materia palpabile non assumeva, in nessun senso, una
struttura corpuscolare, ma i singoli oggetti agivano e reagivano con tutti gli
altri oggetti del mondo... con un comportamento di tipo ondulatorio o
vibratorio dipendente, in ultima analisi, dal ritmico alternarsi a tutti i
livelli delle due forze fondamentali, lo yin e lo yang. I singoli oggetti avevano quindi i loro ritmi
intrinseci. E questi erano integrati… nello schema generale dell'armonia del
mondo».
Col concetto di
campo quantistico, la fisica moderna ha trovato una risposta inattesa alla
vecchia domanda se la materia è costituita da atomi indivisibili o da un continuum
soggiacente ad essa. Il campo è un continuum che è presente dappertutto nello
spazio e tuttavia nel suo aspetto corpuscolare ha una struttura discontinua,
«granulare». I due concetti apparentemente contraddittori sono quindi unificati
e interpretati semplicemente come differenti aspetti della stessa realtà. Come
succede sempre in una teoria relativistica, l'unificazione dei due concetti
opposti avviene in modo dinamico: i due aspetti della materia si trasformano
perennemente l'uno nell'altro. Il misticismo orientale sottolinea un'analoga
unità dinamica tra il Vuoto e le forme da esso create. Dice il Lama Govinda:
«La relazione tra... forma e
vuoto non può essere concepita come uno stato di opposti escludentisi
a vicenda, ma soltanto come due aspetti della stessa realtà che coesistono e
cooperano incessantemente».
La fusione di
questi concetti opposti in un tutto unico è stata espressa in un sūtra buddhista con le
famose parole:
«La forma è vuoto, e il vuoto è
in realtà forma. Il vuoto non è diverso dalla forma, la forma non è diversa dal
vuoto. Ciò che è forma quello è vuoto, ciò che è vuoto quello è forma».
Le teorie dei campi
della fisica moderna non solo hanno portato a una nuova concezione delle
particelle subatomiche ma hanno anche modificato in maniera radicale la nostra
concezione delle forze che agiscono fra queste particelle. In origine, il
concetto di campo era legato a quello di forza, e anche nella teoria dei campi
esso è ancora associato alle forze tra particelle. Il campo elettromagnetico,
per esempio, può manifestarsi come «campo libero» sotto forma di onde/fotoni
che si propagano, oppure può avere la funzione di un campo di forze tra
particelle cariche. In quest'ultimo caso, la forza si
manifesta come scambio di fotoni tra le particelle che interagiscono. La
repulsione elettrica tra due elettroni, per esempio, è mediata da questi scambi
di fotoni.
Questa nuova
concezione della forza può sembrare difficile da capire, ma essa diventa molto più
chiara quando il processo di scambio di un fotone è rappresentato in un
diagramma spazio- tempo. Nel diagramma sono rappresentati due elettroni che si
avvicinano tra loro; uno di essi emette il fotone (indicato con y) nel punto A,
l'altro lo assorbe nel punto B.

Repulsione
reciproca tra due elettroni mediante lo scambio di un f otone
Dopo avere emesso
il fotone, il primo elettrone inverte la sua direzione e modifica la velocità
(come si può vedere dal cambiamento di direzione e d'inclinazione della sua
linea di universo), e così pure fa il secondo elettrone quando assorbe il
fotone. Infine, i due elettroni si allontanano rapidamente, essendosi respinti
l'un l'altro attraverso lo scambio del fotone. L'interazione completa tra gli
elettroni comporterà una serie di scambi di fotoni, e come effetto finale gli
elettroni sembreranno deviarsi l'un l'altro lungo curve continue.
In termini di
fisica classica, si potrebbe dire che gli elettroni esercitano l'uno sull'altro
una forza repulsiva. Questo, tuttavia, è considerato oggi un modo molto
impreciso di descrivere la situazione. Nessuno dei due elettroni «sente» una
forza quando si avvicina all'altro: essi semplicemente interagiscono mediante
lo scambio di fotoni, e la forza non è altro che l'effetto macroscopico
collettivo di questi ripetuti scambi di fotoni. Il concetto di forza perciò non
ha più alcuna utilità nella fisica subatomica: è un concetto classico che noi
associamo (anche se solo in maniera subconscia) all'idea newtoniana
di forza che agisce a distanza. Nel mondo subatomico non ci sono forze di
questo tipo, ma solo interazioni tra particelle, mediate attraverso campi,
cioè, attraverso altre particelle. Perciò, i fisici preferiscono parlare di
interazioni piuttosto che di forze.
Secondo la teoria
dei campi, tutte le interazioni avvengono attraverso lo scambio di particelle.
Nel caso delle interazioni elettromagnetiche, le particelle scambiate sono
fotoni; i nucleoni, d'altro canto, interagiscono attraverso una forza molto più
intensa, quella nucleare, o «interazione forte», che si manifesta come scambio
di un nuovo tipo di particelle chiamate “mesoni”. Esistono molti tipi diversi
di mesoni che possono essere scambiati tra protoni e neutroni. Più i nucleoni
sono vicini tra loro, più sono numerosi e pesanti i mesoni che essi scambiano.
Le interazioni tra nucleoni sono quindi connesse alle proprietà dei mesoni
scambiati e questi, a loro volta, interagiscono fra loro attraverso lo scambio
di altre particelle. Per questa ragione non saremo in grado di capire la forza
nucleare a un livello fondamentale prima di capire l'intero spettro delle
particelle subatomiche.
Nella teoria dei
campi, tutte le interazioni tra particelle possono essere rappresentate con
diagrammi spazio-tempo, e ciascun diagramma è associato a una espressione
matematica che permette di calcolare la probabilità che si verifichi il
corrispondente processo. L'esatta corrispondenza tra i diagrammi e le
espressioni matematiche fu stabilita nel 1949 da Richard
Feynman, e perciò da allora i diagrammi sono noti
come diagrammi di Feynman. Un punto cruciale della
teoria è la creazione e la distruzione di particelle. Per esempio, nel
diagramma precedente il fotone è creato nel processo di emissione nel punto A,
ed è distrutto quando viene assorbito nel punto B. Un processo simile può
essere concepito solo in una teoria relativistica nella quale le particelle non
sono viste come oggetti indistruttibili, ma piuttosto come figure dinamiche che
coinvolgono una certa quantità di energia, che può essere ridistribuita quando
si formano nuove figure.
La creazione di una
particella dotata di massa è possibile solo quando viene fornita l'energia
corrispondente alla sua massa, per esempio in un processo d'urto. Nel caso
delle interazioni forti, questa energia non è sempre disponibile, come succede
quando due nucleoni interagiscono tra loro in un nucleo atomico. In tali casi,
quindi, non dovrebbero essere possibili scambi di mesoni dotati di massa;
tuttavia essi si verificano ugualmente. Per esempio, due protoni possono
scambiare un «mesone π», o «pione», la cui massa è circa un settimo di
quella del protone.
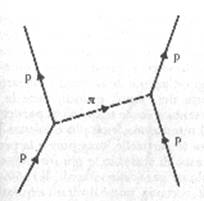
Scambio
di un pione (π) tra due protoni (p)
Le ragioni per le
quali possono avvenire processi di scambio di questo tipo, nonostante
l'apparente mancanza di energia per la creazione del mesone, devono essere
cercate in un «effetto quantistico» connesso con il principio di
indeterminazione. Come si è visto precedentemente, gli eventi subatomici che si
verificano entro un intervallo di tempo breve comportano un'incertezza
nell'energia proporzionalmente grande. Gli scambi di mesoni, cioè la loro
creazione e la successiva distruzione, sono eventi di questo tipo. Essi
avvengono in un intervallo di tempo così breve che l'incertezza nell'energia è
sufficiente a permettere la creazione dei mesoni stessi. Mesoni di questo tipo
sono chiamati particelle «virtuali» e sono diversi dai mesoni «reali» creati
nei processi d'urto, perché possono esistere solo per l'intervallo di tempo
permesso dal principio di indeterminazione. Più sono pesanti, cioè maggiore è
l'energia richiesta per crearli, più è piccolo l'intervallo di tempo permesso
per il processo di scambio. Questa è la ragione per la quale lo scambio di
mesoni pesanti tra nucleoni può avvenire solo quando questi sono molto vicini
tra loro. Lo scambio di fotoni virtuali, viceversa, può avvenire su distanze
illimitate perché i fotoni, essendo privi di massa, possono essere creati con
una quantità di energia indefinitamente piccola. Questa analisi delle forze elettromagnetiche e
nucleari consentì a Hideki Yukawa,
nel 1935, non solo di prevedere l'esistenza del pione, dodici anni prima che
fosse osservato, ma anche di stimarne approssimativamente la massa in base al
raggio d'azione della forza nucleare.
Nella teoria dei
campi, quindi, tutte le interazioni sono rappresentate come scambio di
particelle virtuali. Più forte è l'interazione, cioè più è intensa la «forza»
risultante tra le particelle, maggiore è la probabilità di questo processo di
scambio, e più frequentemente verranno scambiate particelle virtuali. Il ruolo
delle particelle virtuali, tuttavia, non è limitato a queste interazioni. Un
solo nucleone, per esempio, può benissimo emettere una particella virtuale e
riassorbirla poco dopo. Purché il mesone creato scompaia entro il tempo
permesso dal principio di indeterminazione, non c'è nulla che proibisca tale
processo. Il corrispondente diagramma di Feynman per
un neutrone che emette e riassorbe un pione è riprodotto nella figura a p. 255.
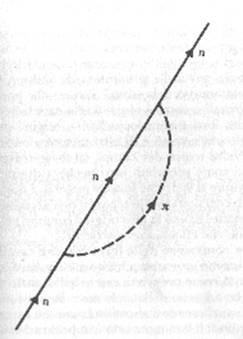
Un
neutrone (n) emette e riassorbe un pione
La probabilità di
siffatti processi di «autointerazione» è molto alta
per i nucleoni a causa della loro forte interazione. Ciò significa che in
realtà i nucleoni emettono e assorbono di continuo particelle virtuali. Secondo
la teoria dei campi, essi devono essere considerati centri di attività continua
e avvolti da nubi di particelle virtuali. I mesoni virtuali devono scomparire
in un tempo brevissimo dopo la loro creazione, il che significa che essi non
possono allontanarsi molto dal nucleone; di conseguenza, la nuvola di mesoni è
molto piccola. Le sue regioni più esterne sono popolate da mesoni leggeri
(soprattutto pioni), poiché i mesoni pesanti, dovendo essere assorbiti dopo un
tempo molto più breve, rimangono confinati nella parte interna della nube.
Ogni nucleone è
circondato da questa nube di mesoni virtuali i quali vivono solo per un periodo
di tempo estremamente breve. Tuttavia, i mesoni virtuali possono diventare mesoni
reali in particolari circostanze. Quando un nucleone è colpito da un'altra
particella che si muove ad alta velocità, una parte dell'energia di moto di
questa particella può essere trasferita a un mesone virtuale per liberarlo
dalla nube. Questo è il modo in cui i mesoni reali sono creati negli urti ad
alta energia. D'altra parte, quando due nucleoni si avvicinano talmente l'uno
all'altro che le loro nubi di mesoni si sovrappongono, può accadere che alcune
delle particelle virtuali non tornino indietro per essere riassorbite dal
nucleone che le ha create inizialmente, ma «saltino dall'altra parte» e siano
assorbite dall'altro nucleone. Così si realizzano i processi di scambio che
costituiscono le interazioni forti.
Questa
rappresentazione mostra chiaramente che le interazioni tra particelle, e quindi
le «forze» tra di esse, sono determinate dalla composizione delle loro nubi
virtuali. Il raggio d'azione di una interazione, cioè la distanza tra le
particelle alla quale avrà inizio l'interazione, dipende dall'estensione delle
nubi virtuali, e la forma particolare dell'interazione dipenderà dalle
proprietà delle particelle presenti nella nube. Quindi le forze
elettromagnetiche sono dovute alla presenza di fotoni virtuali «entro» le
particelle cariche, mentre le interazioni forti tra nucleoni hanno origine
dalla presenza di pioni virtuali e di altri mesoni «entro» i nucleoni. Nella
teoria dei campi, le forze tra particelle appaiono come proprietà intrinseche a
queste ultime. Oggi dunque si vede che forza e materia, i due concetti che
erano così nettamente separati nell'atomismo greco e newtoniano, hanno la loro origine comune nelle figure
dinamiche che chiamiamo particelle.
Questa concezione
delle forze è anche caratteristica del misticismo orientale che considera
movimento e mutamento come proprietà essenziali di tutte le cose e intrinseche
ad esse. «Tutte le cose che ruotano» dice Chang Tsai riferendosi ai cieli «hanno una forza spontanea e
quindi il loro moto non è imposto ad esse dall'esterno»; e nell'I King
leggiamo:
«Esse [le leggi di natura] non
sono circostanze estrinseche alle cose, sono anzi l'armonia del moto, immanente
ad esse ».
Questa antica
descrizione cinese delle forze come simbolo dell'armonia del movimento entro le
cose sembra particolarmente appropriata alla luce della teoria dei campi, nella
quale le forze tra particelle sono viste come riflesso delle forme dinamiche
(le nubi virtuali) inerenti alle particelle stesse.
La teoria dei campi
della fisica moderna ci costringe ad abbandonare la classica distinzione tra
particelle materiali e vuoto. La teoria del campo gravitazionale di Einstein e la teoria dei campi mostrano entrambe che le
particelle non possono essere separate dallo spazio che le circonda. Da una
parte, esse determinano la struttura di questo spazio, mentre dall'altra non
possono venire considerate come entità isolate, ma devono essere viste come
condensazioni di un campo continuo che è presente in tutto lo spazio. Nella
teoria dei campi, il campo è visto come la base di tutte le particelle e delle
loro interazioni reciproche.
“Il campo esiste sempre e
dappertutto, non può mai essere eliminato. Esso è il veicolo di tutti i
fenomeni materiali. E il "vuoto" dal quale il protone crea i mesoni
π. L'esistere e il dissolversi delle particelle sono semplicemente forme
di moto del campo”.
Infine, la
distinzione tra materia e spazio vuoto dovette essere abbandonata quando
divenne evidente che le particelle virtuali possono generarsi spontaneamente
dal vuoto, e svanire nuovamente in esso, senza che sia presente alcun nucleone
o altra particella a interazione forte. Riportiamo qui un «diagramma
vuoto-vuoto» per un processo di questo tipo: tre particelle - un protone (P), un antiprotone (p), e un
pione (π) - emergono dal nulla e
scompaiono nuovamente nel vuoto. Secondo la teoria dei campi, eventi di questo
tipo avvengono di continuo. Il vuoto è ben lungi dall'essere vuoto. Al
contrario, esso contiene un numero illimitato di particelle che vengono
generate e scompaiono in un processo senza fine.

In questo aspetto
della fisica moderna c'è dunque la più stretta corrispondenza con il Vuoto del
misticismo orientale. Analogamente al Vuoto dei mistici orientali, il «vuoto
fisico» - come è chiamato nella teoria
dei campi - non è uno stato di semplice
non-essere, ma contiene la potenzialità di tutte le forme del mondo delle
particelle. Queste forme, a loro volta, non sono entità fisiche indipendenti,
ma soltanto manifestazioni transitorie del Vuoto soggiacente ad esse. Come dice
il sutra, «la forma è vuoto, e il vuoto in realtà è
forma».
La relazione tra le
particelle virtuali e il vuoto è una relazione essenzialmente dinamica; il
vuoto è certamente un «Vuoto vivente», pulsante in ritmi senza fine di
creazione e distruzione. La scoperta della qualità dinamica del vuoto è
considerata da molti fisici uno dei risultati più importanti della fisica
moderna. Dall'avere una funzione di vuoto contenitore dei fenomeni fisici, il
vuoto è passato ad essere una quantità dinamica della massima importanza. I
risultati della fisica moderna sembrano quindi confermare le parole del saggio
cinese Chang Tsai:
“Quando si conosce che il Grande
Vuoto è pieno di ch'i, si comprende che non esistono cose quali il non-essere”.
(da F. Capra, Il Tao della fisica)
|
|
Altri argomenti
del Tao
© www.mimmademaio.com - 2012
|
|